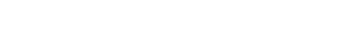Questo articolo è stato pubblicato la prima volta sul numero 1, 8 gennaio 2021, di “Left”.
Questo articolo è stato pubblicato la prima volta sul numero 1, 8 gennaio 2021, di “Left”.
di Cesare Damiano
Lo scorso 27 dicembre in tutta Europa, tranne che in Ungheria dove Orban ha deciso di disattendere gli accordi presi e di iniziare prima, è partito il Vax day, il giorno del vaccino. È una data destinata a cambiare il corso di una storia iniziata lo scorso inverno e che ha sconvolto un intero pianeta: mesi e mesi a combattere una battaglia contro un nemico invisibile ma potentissimo che ha ucciso migliaia e migliaia di persone e impiegato giorno e notte le migliori intelligenze di tutto il mondo per cercare un antidoto, un vaccino, in grado di riportarci alla vita che avevamo, alle nostre abitudini, a quella che oggi ci sembra una libertà immensa come abbracciare l’altro da noi, dare la mano, parlarsi senza usare il metro e una mascherina.
Da oggi il nostro compito, di comunità, è quello di rimboccarci le maniche e provare a ripartire, continuando a rispettare le norme di tutela della salute fino a quando non avremo raggiunto l’immunità di gregge grazie alla vaccinazione di massa. Da oggi – sarebbe meglio dire dall’altro ieri – il compito della politica è quello di mettere in campo un piano di ricostruzione nazionale sulle macerie lasciate dal Covid. Economia, occupazione, salute pubblica, relazioni sociali, istruzione, ricerca: c’è bisogno di un progetto di lungo respiro che sappia lanciarci nel futuro, in un futuro con un paradigma economico che superi il turbocapitalismo liberista che ci ha portato dove eravamo dieci mesi fa, prima dell’arrivo della pandemia: in una situazione già segnata dalla crisi e da diseguaglianze sociali mai viste precedentemente.
Durante la prima ondata pandemica il nostro Governo (e i partiti della maggioranza), malgrado sapessimo davvero poco del Covid 19, è stato in grado di assumere alcune decisioni efficaci, a partire da quella più dolorosa, il lockdown, che ha rappresentato l’unica vera arma di difesa contro il virus, come dimostrano i dati che ad aprile registravano una media di 518 decessi al giorno, contro gli 11 di agosto. Anche le azioni di sostegno all’economia hanno temperato le misure del blocco totale del Paese: dalla Cassa Integrazione – estesa anche alle aziende con un solo dipendente – al blocco dei licenziamenti che, come ha sottolineato Bankitalia, ha salvato 600 mila posti di lavoro; fino ai cosiddetti “ristori” che hanno rappresentato, pur con tutti i ritardi, un sostegno per il lavoro autonomo, le famiglie e le categorie più deboli.
La seconda ondata ancora in corso, invece, ha messo in luce alcune incongruenze non da poco. Siamo l’unico Paese in Europa che parla di crisi di Governo e di rimpasto in un momento come questo. La politica, mentre tutto intorno muta, mentre ognuno di noi è cambiato nel suo agire quotidiano, resta ferma, sempre uguale a se stessa, prigioniera delle sue nevrosi. Avremmo bisogno di statisti e non di politicanti a caccia di qualche zero virgola di potere in più. Anche perché, come rilevano diversi sondaggi, alcuni partitini di maggioranza particolarmente petulanti rischiano di sparire. Come ha più volte affermato anche il segretario del Pd Nicola Zingaretti, è necessario compiere “scelte strategiche per l’Italia in maniera costruttiva e responsabile”, con quel senso di concretezza che dovrebbe appartenere a tutta la classe dirigente. Di maggioranza e di opposizione.
Uscire dal solito teatrino dove ognuno recita la sua parte, sempre uguale a se stessa, e provare a sperimentare nuovi percorsi che riavvicinino governanti e governati in un nuovo Patto Sociale che punti al superamento dell’interesse personale di breve, brevissimo termine (fino ad esaurirsi nello spazio di un sondaggio di fine settimana) e rimetta al centro un nuovo umanesimo, sarebbe l’obiettivo minimo da perseguire.
Ursula von der Leyen ha sottolineato come, di fronte alla crisi del 2008, i Governi reagirono con un rigorismo dogmatico (Grecia, Spagna, Portogallo e Italia hanno pagato a caro prezzo quell’approccio) che ha fatto cedere importanti fette di welfare sociale ai Paesi governati dai “liberisti de noantri”, mentre oggi, l’Europa ha scelto di agire in direzione opposta.
C’è bisogno di un piano neokeynesiano che archivi questo modello liberista di capitalismo esasperato e avido che ha reso più povera una parte consistente del mondo e sempre più ricca una ristretta fascia di persone. Infatti, il ridimensionamento del ceto medio, in quello che un tempo definivamo l’occidente capitalistico, è sotto gli occhi di tutti, così come l’aumento della povertà nel mondo e in Europa.
Ce lo ha detto papa Francesco: “Diamo un’occhiata al mondo così com’è. Guerre ovunque. Stiamo vivendo la terza Guerra Mondiale a pezzi… Bambini senza scuola, persone affamate, persone che non hanno assistenza sanitaria, il vasto numero di persone che non ha acqua corrente, che non ha accesso al minimo per vivere con dignità… Diamo un’occhiata a certe periferie”. E’ da qui che dobbiamo ripartire, da questa realtà, da questa nuova guerra che si sta consumando ovunque per provare a eliminare le storture.
Adesso abbiamo un’occasione, una ingente quantità di risorse che arriverà nel nostro Paese e dunque dobbiamo decidere come impiegarle. Il debito di un Paese può essere “buono” se fatto per investire nella crescita o può essere “tossico” se finalizzato a interessi di piccolo cabotaggio.
Qualcuno ha detto che c’è bisogno di un nuovo piano Marshall: preferisco pensare a piano che non conosce precedenti, un unicum, un grande punto di svolta per il nostro Paese e un inedito scatto di reni di una intera classe dirigente politica. Pochi punti programmatici che siano in grado di cambiare il volto del Paese, la cui esecuzione dovrebbe essere seguita passo passo non da mega task force, ma da un qualificato team di professionalità e una salda direzione politica, con capacità decisionali snelle e un chiaro tracciamento delle responsabilità.
Cosa fare? Intanto investimenti nelle infrastrutture materiali e immateriali (il ponte Morandi è l’emblema dell’avidità del capitalismo a scapito della sicurezza pubblica), a partire dalla lotta al dissesto idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio; nella green economy; nella digitalizzazione, nella banda larga, nella ricerca. Dobbiamo rimettere la scienza al centro, come motore di sviluppo di qualità e il welfare come infrastruttura sociale fondante di una collettività. Abbiamo bisogno di un ammortizzatore sociale universale senza distinzione tra lavoro dipendente e autonomo; dobbiamo ridisegnare il quadro di tutele intervenendo sulla profondità delle disuguaglianze. Non possiamo assistere impotenti alla profonda e crescente frattura che ancora persiste tra Nord e Sud: il Covid, come se ce ne fosse ancora bisogno, ce lo ha ricordato con alunni che, nel Mezzogiorno, non hanno potuto seguire la didattica a distanza perché senza connessione o senza la possibilità economica di acquistare iPad o computer. Con strutture ospedaliere insufficienti, altre realizzate e mai finite a causa di sprechi di denari, corruzione, mala gestione. Con un’economia a due tempi e infrastrutture che tagliano in due il Paese.
Con i fondi del Recovery Plan abbiamo l’occasione di sanare le fratture, di decidere il tempo e il modo di un nuovo modello economico, di una sanità efficiente e di prossimità di pari livello in tutto il territorio, di una istruzione che dia pari opportunità reali e non virtuali, di misure di sostegno finalizzate a rendere dignitosa la vita di ognuno, di investimenti massicci nella ricerca e in nuove filiere produttive in grado di creare lavoro nuovo e solido. Potremmo aggiungere “sano”, dove per sano vanno intese le condizioni in cui si è chiamati a lavorare. Abbiamo bisogno di un modello sociale nel quale il tempo della discontinuità del lavoro deve essere accompagnato dalla continuità delle tutele, se non vogliamo trasformare i nuovi “lavoratori poveri” nei futuri pensionati poveri.
C’è bisogno di “Politica”, quella con la P maiuscola. Mai come adesso.