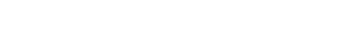Questo articolo è stato pubblicato la prima volta sul numero 39, 25 settembre 2020, di “Left”.
Questo articolo è stato pubblicato la prima volta sul numero 39, 25 settembre 2020, di “Left”.
di Cesare Damiano
Per avere un’idea della dimensione della crisi economico-sociale innescata dall’emergenza Covid-19, il commento forse più efficace è stato pronunciato, alcuni giorni fa, dal Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in occasione del suo intervento all’EuroScience Open Forum di Trieste. Visco ha ricordato come il Pil italiano sia tornato ai livelli del 1993. Mentre quello pro-capite è sceso, addirittura, ai valori degli anni Ottanta.
Un crollo che, sempre secondo l’analisi del Governatore, è stato certamente determinato dalla virulenza della pandemia e dalle inevitabili limitazioni delle relazioni sociali, con le conseguenti ricadute sul processo produttivo di interi settori, ma che si è abbattuto su un tessuto economico che fin dagli anni Novanta soffre di tassi di crescita molto limitati. Limiti che sono frutto, da un lato, dell’inadeguatezza della Pubblica Amministrazione che non ha saputo tenere il passo dell’innovazione; dall’altro dell’inidoneità di un sistema produttivo affetto da “nanismo” e da una bassa capacità di introdurre buone pratiche manageriali, adottare nuove tecnologie e investire in capitale umano. Con la conseguenza che si è, così, alimentato un circolo vizioso di salari bassi e scarsa richiesta di lavoratori qualificati.
Non possiamo né dobbiamo dimenticare che, dopo la crisi del 2008 – nel decennio 2009-2018 – 816mila italiani si sono trasferiti in un Paese straniero (specialmente giovani ad alto tasso di istruzione). Mentre solo 333mila sono rimpatriati in Italia.
A fronte di tale scenario il Governo si è trovato a dover gestire – in tempo reale – l’emergenza economico-sociale prodotta dalla pandemia; la quale, nella sua portata globale, sta ancora manifestando tutta la sua devastante azione in tanta parte del mondo.
Per tracciare un giudizio politico sull’azione di Governo, in queste circostanze è, perciò, necessario mettere in evidenza alcuni punti. In primo luogo, le misure di difesa della popolazione nel momento di massima emergenza, a partire da marzo, sono state efficaci. Dopo il primo, terribile, periodo di picco della malattia, sul piano sociale e sanitario si è riusciti – grazie al lockdown e alle misure connesse – a contenere la diffusione dell’infezione. In secondo luogo, l’azione di protezione sociale attuata con l’estensione della Cassa Integrazione, il divieto di licenziamento e alcuni bonus, ha enormemente attutito le conseguenze sul nostro – come affermato da Visco – già fragile sistema produttivo e sull’universo del lavoro. Il prezzo è stato quello di una crescita dell’indebitamento dello Stato. Ma ben altri e terribili costi sociali sono stati scongiurati.
Detto questo, la perfezione non è certo una caratteristica della risposta a una emergenza imprevedibile. Questo sia detto non come giustificazione, ma come osservazione della realtà. E, proprio nel confronto con la realtà, si è via via imparato, corretto e adeguato il nostro comportamento. Come nel caso della Cassa Integrazione che è state allargata con la causale COVID per meglio rispondere allo sviluppo della crisi.
Andiamo a vedere, nei numeri, come si è sviluppata la risposta sul piano degli ammortizzatori sociali. Con i tre maxi-decreti legge varati da marzo ad agosto – il decreto” Cura Italia”, il decreto “Rilancio” e il decreto “Agosto” – sul piano degli interventi approntati per la gestione dell’emergenza occupazionale, il Governo ha predisposto un ampio ventaglio di misure di tutela per mitigare gli effetti della pandemia sul reddito delle diverse categorie di lavoratori interessati. È stata impegnata una straordinaria mole di risorse finanziarie, corrispondenti complessivamente a più di 42 miliardi di euro.
Il totale degli stanziamenti approntati con il decreto “Cura Italia” ammonta a 8 miliardi di euro; un po’ più di 23 miliardi sono stati impegnati con il decreto “Rilancio”; 11 miliardi con il decreto “Agosto”.
Come noto, il grosso di tali risorse è stato appannaggio degli interventi di concessione della Cassa Integrazione Ordinaria, degli assegni ordinari di integrazione salariale e della Cassa Integrazione in Deroga, per importi di quasi 5 miliardi di euro con il decreto “Cura Italia”, oltre 16 miliardi di euro con il decreto “Rilancio” e poco meno di 8 miliardi con il decreto “Agosto”.
Tuttavia, una parte consistente delle risorse impegnate – quasi 3 miliardi di euro per il decreto “Cura Italia”, 6 miliardi di euro per il decreto “Rilancio” e 0,5 miliardi di euro per il decreto “Agosto” – è stata indirizzata anche al sostegno del reddito delle molte categorie di lavoratori che attualmente risultano escluse dal sistema degli ammortizzatori sociali (professionisti, lavoratori autonomi, partite Iva, collaborazioni coordinate e continuative, lavoratori domestici ecc.). Ciò ha messo in evidenza, ancora una volta, la necessità di un definitivo intervento di riforma degli ammortizzatori sociali che completi il percorso, avviato nella scorsa legislatura, per la realizzazione di un sistema di protezione sociale che progressivamente, ma entro tempi certi e ravvicinati, assicuri a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori dipendenti o autonomi, in caso di disoccupazione involontaria e in caso di contrazione dell’attività produttiva attraverso una cassa integrazione semplificata, trattamenti economici tali da assicurare loro un’esistenza libera e dignitosa.
Da notare, inoltre, con riferimento alle misure di finanziamento della Cassa Integrazione con causale “Covid-19” – creata ad hoc in corso d’opera – che, come illustrato dalla relazione dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio in merito al decreto “Agosto”, “nel trimestre maggiormente colpito dall’emergenza e dal lockdown (marzo-maggio) la spesa effettiva è stata, senza considerare eventuali ritardi nelle erogazioni, di 3,8 miliardi, meno di un terzo del totale”. E che “i beneficiari di integrazioni con causale COVID-19 ammonterebbero in totale a oltre 2,2 milioni di lavoratori, per una maggiore spesa, inclusiva degli assegni per il nucleo familiare, di poco più di 8,2 miliardi”.
Le rilevazioni dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio evidenziano che le stime di spesa si sono rilevate anche in questa occasione, (dal momento che si attivano dei diritti), ben più elevate rispetto all’effettivo “tiraggio” della domanda. Per di più, va ricordato come lo stesso Ufficio Parlamentare di Bilancio, alla fine del luglio scorso, avesse rilevato che – in base all’incrocio dei dati del monitoraggio dell’Inps con quelli della fatturazione elettronica dell’Agenzia delle Entrate, nel primo semestre del 2020 rispetto al primo semestre del 2019 – “oltre un quarto delle ore è stato tirato da imprese che non hanno subito alcuna riduzione” dell’attività.
Da qui, la necessità di affinare gli strumenti, con l’impegno politico a non disperdere per altre finalità le risorse effettivamente risparmiate. Esse andrebbero, invece, momentaneamente accantonate in vista della scadenza degli ammortizzatori sociali e del blocco dei licenziamenti, per ulteriori misure di sostegno e di tutela nei settori che dovessero ancora versare in uno stato di depressione rispetto all’auspicata ripresa economica. Non a caso abbiamo sempre insistito sulla necessità di garantire Cassa Integrazione e blocco dei licenziamenti almeno (sottolineo almeno) fino alla fine dell’anno.